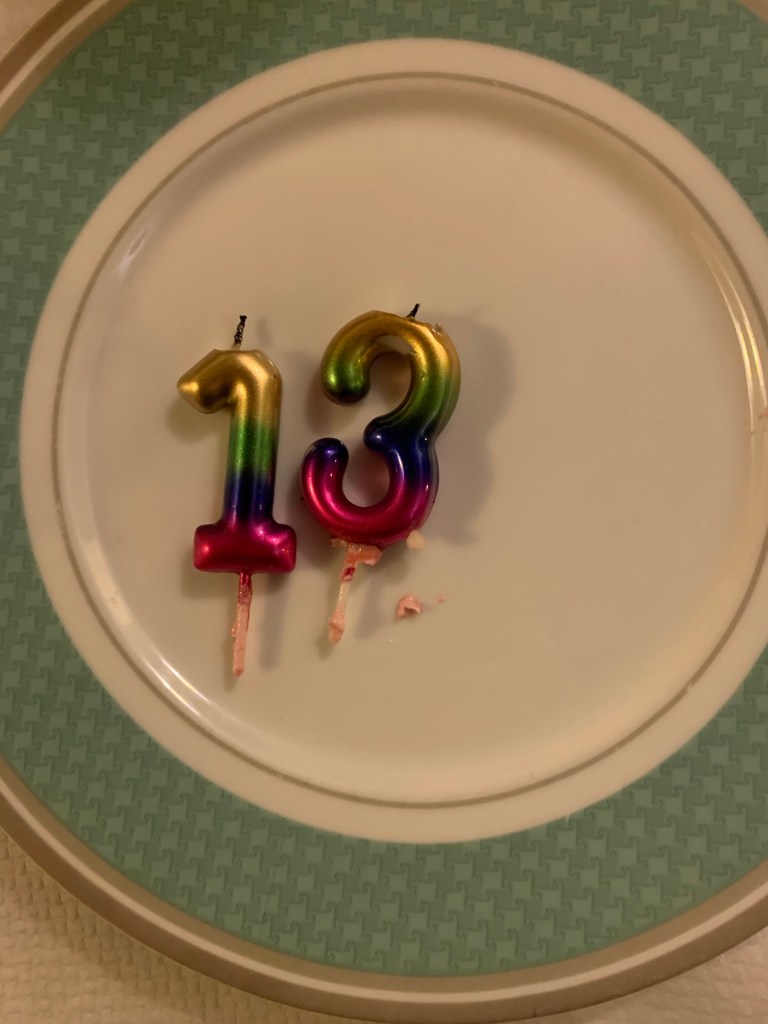A Montecalvario la notte arriva in silenzio, scivola giù dai vicoli come un velo pesante che copre ciò che il mondo preferisce ignorare.
Sui gradini consumati siedono uomini senza casa, mani vuote, occhi che hanno visto troppo, storie che nessuno chiede più di ascoltare. Odorano di pioggia antica, di porte chiuse, di treni che non si sono mai fermati per loro.
La gente passa, passa sempre, passa comunque. Il mondo non si ferma a guardare: ha paura di scoprire che basta un soffio per cadere nello stesso punto.
Solo i bambini li vedono davvero. Si fermano un istante, con quello stupore pulito che non sa ancora voltarsi dall’altra parte. Ma subito una mano adulta li strattona via, come se guardare fosse un pericolo, come se la compassione fosse una colpa.
E loro restano lì, i vagabondi, con gli occhi lucidi come vetri rotti, a chiedersi se da qualche parte esista ancora una parola capace di chiamarli per nome.
A Montecalvario dormono seduti, per non sognare troppo. E il vento, passando, fa ciò che nessuno fa più: li sfiora piano, come si fa con chi non ha più niente tranne la propria solitudine.
Silvia Rosa